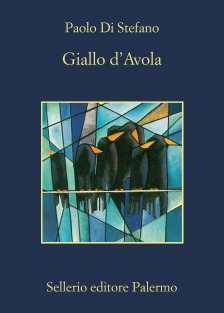di Salvo Zappulla
Ho letto quasi tutti i libri di Paolo Di Stefano, mi piace la capacità dell’autore di scavare dentro l’anima delle persone, mi piace la sua profondità di pensiero. E leggendoli mi sono reso conto che sono legati da un comune denominatore: la ricerca costante di dare voce agli ultimi, ai disperati, a chi non ha nessuno che li difenda. E mi piace il fatto che tratti argomenti così delicati con pudore e discrezione. Ci sono giornalisti d’assalto, che urlano e sgomitano per farsi sentire. E ci sono giornalisti come Paolo Di Stefano che bussano prima di entrare. La classe non è acqua. Il suo più recente romanzo “Giallo d’Avola” edito da Sellerio racconta la storia dei fratelli Gallo, i due mezzadri di Avola che nel 1954 si ritrovarono coinvolti in una strana vicenda di cronaca nera. Ignoranza, sopraffazione, confusione e galera facile per chi proviene dal basso fanno da protagonisti. Paolo su questa storia ha imbastito una trama di rara maestria. “La catastròfa”, sempre pubblicato per Sellerio, è un’altra vicenda scabrosa. Una catastrofe di vaste proporzioni avvenuta a Marcinelle, in Belgio, l’8 agosto 1956, nel distretto carbonifero di Charleroi. Le condizioni di insicurezza e abbandono là sotto trasformarono un semplice equivoco in una delle stragi più gravi della storia mineraria. Dei 274 lavoratori scesi per iniziare il turno del mattino, 262 (di cui 136 immigrati italiani) caddero vittime di un banale incidente che provocò un incendio alla profondità di 975 metri. Erano in gran parte meridionali: abruzzesi, pugliesi, siciliani, uomini del sud con il cuore grande e le tasche vuote, capaci di spartirsi un pezzo di formaggio con il compagno che non aveva nulla da mangiare. Persone barattate con una manciata di carbone di cui francamente, a parte i familiari e gli amici, non importava niente a nessuno. Operai, gente umile cancellata dalla memoria con un moto di fastidio. Lo Stato italiano per primo che non si degnò minimamente di inviare un rappresentante sul luogo della tragedia; la giustizia e le autorità belghe che avevano fretta di chiudere l’incidente di percorso, evitando polveroni dannosi all’immagine del Paese. Eppure la catastròfa aveva reciso vite di lavoratori, distrutto famiglie, infranto i sogni e l’avvenire di quanti avevano lasciato la propria terra per un pezzo di pane. Le scene descritte da Paolo, con le mogli dei minatori che piangono e si disperano davanti ai cancelli della miniera in fiamme, sono sintomatiche e strappano al lettore una fitta lancinante di dolore. Ci si sente impotenti di fronte a quegli esseri umani e alla loro tragedia, si sente il dovere di cingerli in un abbraccio ideale, ci riportano a un senso di fratellanza tra gli uomini, che sempre dovrebbe essere la nostra stella polare. Le testimonianze che il giornalista fa emergere sono di rabbia, rassegnazione, sconforto, risentimento. Ognuno reagisce a modo suo ma sempre con grande dignità, caratteristica della gente umile, abituata a cadere e a risorgere con le proprie forze. Molti erano bambini allora e si ritrovarono orfani in terra straniera. La bellezza e il fascino di questo libro consiste nel fatto di portare all’indietro le lancette dell’orologio, riparare a un gravissimo torto, ridare vita e identità a quanti frettolosamente e colpevolmente sono stati destinati all’oblio. Erano esseri umani con una sola esistenza da spendere, non anelli di una catena di montaggio. Paolo a distanza di anni è ridisceso in quella miniera, tra le fiamme dell’inferno, li ha scossi quei cadaveri, li ha riportati in vita, dato loro una nuova dignità, una nuova veste, una nuova voce per raccontare al mondo il loro strazio. A questo punto che importa di chi furono le responsabilità, se di Iannetta che provocò l’incidente o di qualche altro che aveva responsabilità maggiori delle sue. Il cronista ha raccolto le sue testimonianze, si è documentato, ha tastato con mano le ferite ancora aperte, ci ha messo dentro tutto il suo talento di scrittore, la delicatezza e la sensibilità che lo contraddistinguono, le ha offerte al lettore affinché si faccia la propria opinione e, soprattutto, conservi nella memoria il ricordo di tante vite spezzate, fratelli, emigranti che hanno contribuito alla crescita del nostro Paese. Emigranti come quelli che arrivano da noi e spesso ci dimentichiamo di trattare come esseri umani. “Nel cuore che ti cerca”, pubblicato da Rizzoli, raggiunge vette di intenso lirismo. La storia di una ragazzina nelle mani di un aguzzino. Rita ha dieci anni appena quando conosce il suo calvario. Rapita da un maniaco, rinchiusa in una squallida stanzetta tra topi e avanzi di cibo, con un televisore a tenerle compagnia, e seviziata per lunghissimi interminabili anni. Paolo Di Stefano in questo libro ci racconta la storia di un’infanzia violata prendendo spunto da un fatto di cronaca, (la storia di Natasha Kampusch, la ragazza scomparsa a Vienna nel ’98 e tenuta sequestrata per otto anni) sviluppa un noir psicologico dove i ruoli tra vittima e carnefice si intrecciano ambiguamente. Un tema che ricorre spesso nei suoi romanzi. Rita prova odio e affetto per il suo aguzzino, rabbia e speranza, più volte avrebbe la possibilità di fuggire ma rimane inerme accettando la sua condizione di schiavitù. È convinta di poterlo dominare, tra i due è l’uomo a sottostare, in quanto debole, in quanto morbosamente malato. Un romanzo intenso e coinvolgente, a tratti commovente, tremendamente attuale, che contiene elementi forti. Parallelamente la storia procede con l’incessante ricerca del padre della ragazza, un giornalista fallito, con una situazione familiare difficile, ma tutto sommato un personaggio positivo, caparbio, non privo di slanci poetici, il quale non intende rassegnarsi alla perdita della figlia. Pagine di oscura prigionia e bagliori del mondo esterno fanno da contrasto connotando la storia di una propria impronta stilistica. La tensione emotiva della trama cresce vertiginosamente con lo scorrere degli eventi. Di Stefano compie un viaggio esplorativo nei labirinti dell’animo umano, apre voragini di dolore, percorre tragitti di profonda inquietudine, una sorta di ricamo interiore sulla complessità e la fragilità della psiche, con finezza di scrittura e acume introspettivo, a un ritmo serrato che coinvolge il lettore. Una storia che suscita orrore, fastidio, risentimento, tristezza, ma anche tanta tenerezza. Una miscela esplosiva di sentimenti contrastanti, con la sua severa morale capace di smuovere le coscienze. “Nel cuore che ti cerca” è stato finalista al premio Strega e al Supercampiello.
Proprio prendendo spunto da questa storia, che mi ha colpito molto, inizia la nostra chiacchierata
- Paolo, questa è una storia dura, dall’impatto violento, perché hai voluto raccontarla ai tuoi lettori?
Potrei rispondere che non sono io ad essere stato attratto da quel fatto ma è stato quel fatto a inseguirmi. La realtà è che uno scrittore, in genere, vive di ossessioni: una delle mie, che mi insegue (appunto) da quando ho cominciato a scrivere, è l’infanzia minacciata dagli adulti, dal mondo, dal destino, dalla malattia eccetera. L’infanzia minacciata, l’infanzia cui per qualche ragione è impedito di crescere. E’ un’immagine che mi risulta quasi insopportabile: non riesco a tollerare che un bambino soffra, mi pare profondamente ingiusto e inaccettabile, e forse è per questo che ci scrivo sopra i miei romanzi, dal primo (“Baci da non ripetere”) a “Tutti contenti”. Quando l’infanzia si trova, per qualche ragione, a sfiorare la tragedia o la morte, la mia sensibilità si accende quasi furiosamente e mi costringe a scrivere per liberarmi (almeno provvisoriamente) di quel trauma. Ecco perché mi sono messo a raccontare la storia di Rita. Ma alla fine forse per una risposta più convincente potrei ricorrere a Gadda: “Il mio libro è il prodotto di una normale attività fisiologica: l’ho scritto per la stessa ragione per cui il mio cuore batte, i miei polmoni respirano…”.
- Certi traumi infantili si ripercuotono negativamente per l’intera esistenza, e spesso elementi esterni intervengono quando un minore non è protetto dai genitori. Quanto è importante il calore di una famiglia sana per la formazione di un individuo?
Mi rendo conto che continuo a girare intorno a questi temi trovando solo risposte parziali. Ho come l’impressione che le famiglie “sane” tradizionalmente intese non esistano più: c’è sempre qualche ragione endogena o esogena che interviene a turbare un equilibrio in genere già fragile. Tuttavia, è chiaro che la famiglia rimane il luogo centrale per la formazione (e per la deformazione, purtroppo) individuale. Per questo, la famiglia è sempre più un nucleo tematico interessante per la letteratura: è una sorta di inesauribile motore di immagini e visioni del nostro tempo. È come se in essa fosse contenuta una forza mitica di tensioni primarie. Me lo ha fatto notare Gabriele Pedullà in una sua recensione apparsa sul “Manifesto”: in fondo, la pedofilia che io racconto è il sintomo estremo dell’impazzimento in atto del ciclo delle generazioni. Il pedofilo non è oggi colui che sovverte l’ordine biologico ma colui che rende manifesto un principio più generale di una società di lolite dodicenni e settantenni. Una società fatta di adulti infantili e di bambini costretti a maturare troppo presto.
- Rita, la protagonista del tuo romanzo, instaura un legame quasi di complicità con il suo carceriere, chiamato da lei affettuosamente “Il signor Sergio”. Si sviluppano tra carnefice e vittima quei meccanismi contorti che rendono quest’ultima estremamente debole, incapace di reagire. Nel tuo romanzo scavi molto sulla fragilità della psiche umana. Cosa hai voluto fare emergere?
Non c’è intenzionalità nel mio racconto. Dunque, non posso dire di aver voluto far emergere qualcosa. Semplicemente, man mano che procedevo nella scrittura e via via che i personaggi prendevano voce forma e vita mi accorgevo che affioravano, a mia insaputa, meccanismi psicologici ambigui, doppi. Rita cominciava a dire di essere lei la più forte, quasi volesse proteggere il suo carceriere. Quando accadono delitti del genere, la televisione e le cronache dei giornali non ci dicono mai abbastanza: raccontano questi fatti restando in superficie, descrivendone le dinamiche e magari tirando fuori dal cappello ogni tanto qualche curiosità più o meno pruriginosa. Soprattutto non mettono mai in gioco i sentimenti, le psicologie delle persone, le emozioni profonde e autentiche. Per capire davvero ci vuole qualcosa in più. Ecco, io sono partito da lì, da dove poteva partire la letteratura, dalle parole e dalle emozioni, dalle parole che esprimono emozioni. E da lì a poco a poco si sono formati i personaggi. Direi che ho scritto questo libro per dare a Rita – ma anche a suo padre Toni Scaglione – la possibilità di raccontare la sua tragedia perché tornasse a vivere nel mondo. Per questo ho fatto un enorme sforzo di empatia. Ho cercato di immedesimarmi in lei e di lasciarla parlare dentro di me. Via via che il lavoro procedeva, questo processo di identificazione mi riusciva sempre più naturale. Mi sentivo come una sorta di ventriloquo che trascriveva sulla pagina la fragilità, le paure, le fantasie raccontate dalla ragazzina attraverso di me.
- Tu sei originario di Avola (SR). Ad Avola c’è l’associazione di don Di Noto che si batte incessantemente contro la pedofilia, un’ associazione di volontari. Pensi che le Istituzioni facciano abbastanza per combattere il triste fenomeno degli abusi sui minori?
I bambini vittime di abusi crescono in maniera esponenziale e preoccupante. Ammiro moltissimo le persone che si battono contro questa sciagura sociale. Ma non so se le Istituzioni possano davvero fare qualcosa attraverso dei decreti legge o altro. Ritengo piuttosto che si tratti di questioni più profonde non sanabili con atti legislativi o di polizia. Si tratta di questioni che affondano le radici nei valori culturali e morali della nostra società. Viviamo un’epoca di capovolgimenti spaventosi che rischiano di “giustificare” ogni tipo di deviazione o di perversione. Per esempio, trovo inammissibile l’uso che viene fatto in pubblicità e in televisione del corpo femminile e dell’infanzia. Bisognerebbe cominciare da una rivoluzione dei costumi e della cultura.
- Come si concilia la tua attività di giornalista con quella di scrittore?
Da un po’ di tempo le due attività convivono senza troppo confliggere. Sul piano pratico, è più semplice che in passato, perché essendo ormai da sette anni un inviato del Corriere non ho obblighi stretti di presenza in redazione e i tempi di lavoro sono molto più flessibili. Dunque posso organizzare meglio i tempi della scrittura “creativa”. Ma anche sul piano teorico le cose si sono semplificate: mentre prima pensavo che non dovessero esserci sovrapposizioni di sorta, oggi sono convinto che l’occhio e l’orecchio del giornalista possono essere utilissimi allo scrittore. E riutilizzo nei romanzi molti materiali raccolti sul campo. Certo, poi bisogna sempre tener ben distinte le cose nell’atto della scrittura: e cioè non cedere mai alla tentazione di fare il giornalista scrivendo romanzi e di fare lo scrittore facendo articoli di giornale.
*Paolo Di Stefano è nato ad Avola (Siracusa) nel 1956. È inviato del «Corriere della Sera». Ha pubblicato inchieste e romanzi, tra cui Baci da non ripetere (1994, Premio Comisso), Tutti contenti(2003, Superpremio Vittorini e Flaiano), Nel cuore che ti cerca (2008, Premio Campiello e Brancati).